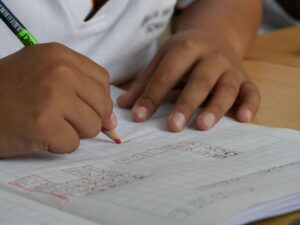Quando si parla di DSA, spesso si fa riferimento a bambini o ragazzi che “fanno fatica a scuola”. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa sigla? I Disturbi Specifici dell’Apprendimento, conosciuti appunto come DSA, non sono sinonimo di pigrizia, disattenzione o mancanza di impegno. Sono condizioni neurobiologiche che influenzano alcune abilità legate all’apprendimento, pur in presenza di un’intelligenza nella norma e di adeguate opportunità scolastiche.
Per chi vive direttamente o indirettamente questa realtà, comprendere a fondo cosa sono i DSA è fondamentale. Significa rompere i pregiudizi, offrire strumenti di supporto efficaci e creare un ambiente scolastico ed educativo che sia davvero inclusivo. I Disturbi Specifici dell’Apprendimento non si “vedono”, ma si manifestano nel disagio di chi non riesce a leggere come gli altri, nella frustrazione di chi fatica a scrivere correttamente e nella rabbia di chi studia tanto ma continua a commettere errori nei calcoli.
Indice dei contenuti
- Le 4 tipologie di DSA: caratteristiche e differenze
- Cosa sono i disturbi specifici dell’apprendimento
- Cosa fare in caso di sospetto DSA: dalla scuola alla diagnosi
- Il percorso per la diagnosi certificata dei DSA
- La normativa di riferimento: la Legge 170/2010
- Vivere con i DSA: un approccio inclusivo per valorizzare le potenzialità
- Domande frequenti (FAQ)
Le 4 tipologie di DSA: caratteristiche e differenze
| Tipologia di DSA | Caratteristiche principali |
|---|---|
| Dislessia | Difficoltà nella decodifica del testo scritto. Lettura lenta e con errori, confusione di lettere simili (b/d), fatica nella comprensione del testo. |
| Disortografia | Difficoltà nella componente ortografica della scrittura. Errori come omissioni, inversioni di lettere, uso scorretto di doppie e accenti. |
| Disgrafia | Difficoltà nell’aspetto motorio della scrittura. Grafia poco leggibile, disordinata, con lettere di dimensioni irregolari e mal allineate. |
| Discalculia | Difficoltà nelle abilità numeriche e di calcolo. Problemi con le operazioni, memorizzazione delle tabelline, comprensione delle quantità. |
Cosa sono i disturbi specifici dell’apprendimento
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento sono definiti “specifici” perché riguardano in modo circoscritto determinate abilità scolastiche di base: lettura, scrittura e calcolo. Questo significa che non coinvolgono l’intero funzionamento cognitivo. Un bambino con DSA può possedere una vivace intelligenza, grande creatività e notevoli capacità di ragionamento, ma incontrare difficoltà significative nel leggere un testo o nell’eseguire una divisione. Non dipendono da fattori ambientali, culturali o da un insegnamento inadeguato e non sono il risultato di una scarsa motivazione.
La neurodiversità alla base dei DSA
Alla base dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento c’è una condizione di neurodiversità. Questo termine indica che il cervello di una persona con DSA elabora le informazioni in un modo differente rispetto allo standard. Questo “diverso funzionamento” si traduce in tempi più lunghi o in errori frequenti nelle attività che per gli altri diventano automatiche, come la lettura ad alta voce o il calcolo a mente. È importante sottolineare che i DSA si manifestano in modo unico da persona a persona; per questo una valutazione accurata è essenziale per definire un intervento mirato ed efficace.
I DSA riconosciuti ufficialmente sono quattro. Ognuno di questi disturbi riguarda una specifica area dell’apprendimento e può manifestarsi con livelli di gravità differenti, spesso anche in comorbilità tra loro, ovvero in associazione con altre condizioni come il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD).
In tutti questi casi, una diagnosi e un intervento precoci sono determinanti per evitare che le difficoltà scolastiche si trasformino in disagio psicologico e in un calo dell’autostima.
Cosa fare in caso di sospetto DSA: dalla scuola alla diagnosi
Quando un genitore o un insegnante notano difficoltà persistenti, la cosa migliore da fare è non minimizzare, ma approfondire la situazione con un approccio costruttivo. I primi segnali possono emergere già nella scuola primaria, ma è importante distinguerli dalle normali difficoltà di apprendimento che ogni bambino può incontrare.
I primi segnali e il ruolo di famiglia e insegnanti
Il primo passo è un confronto aperto tra famiglia e insegnanti per condividere le osservazioni. Se i dubbi persistono, è consigliabile avviare un percorso di valutazione specialistica, come indicato anche nelle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità. La ricerca scientifica continua a fare progressi per migliorare i metodi di identificazione precoce e definire interventi sempre più efficaci.
Il percorso per la diagnosi certificata dei DSA
La diagnosi di DSA può essere effettuata da un’équipe multidisciplinare presso i servizi pubblici (come il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL) oppure presso professionisti privati accreditati. Questa équipe è solitamente composta da figure come il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il logopedista. Ricevere una diagnosi certificata non è un’etichetta, ma un punto di partenza prezioso: permette di accedere a tutele specifiche, personalizzare il percorso scolastico e, soprattutto, restituire serenità e fiducia al bambino, che finalmente comprende l’origine delle sue difficoltà.
La normativa di riferimento: la Legge 170/2010
In Italia, i DSA sono tutelati dalla Legge 170/2010, una normativa che ha rappresentato una svolta per l’inclusione scolastica. La legge stabilisce il diritto degli studenti con diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento a un percorso didattico personalizzato, che valorizzi le loro risorse e compensi le loro fragilità.
Il piano didattico personalizzato (PDP): strumenti e misure
Lo strumento principale previsto dalla legge è il Piano Didattico Personalizzato (PDP), un documento redatto dalla scuola in accordo con la famiglia. Il PDP definisce le strategie didattiche e gli strumenti necessari, tra cui:
- Strumenti compensativi: come mappe concettuali, sintesi vocale, calcolatrice, computer con correttore ortografico, che aiutano l’alunno a svolgere compiti altrimenti difficili.
- Misure dispensative: come la riduzione dei compiti scritti, l’esonero dalla lettura ad alta voce in classe o tempi più lunghi per le verifiche, che evitano di esporre lo studente a situazioni di forte stress e fallimento.
Vivere con i DSA: un approccio inclusivo per valorizzare le potenzialità
Riconoscere i Disturbi Specifici dell’Apprendimento non significa limitare una persona, ma al contrario, darle l’opportunità di esprimere il proprio potenziale. Un approccio basato sull’inclusione e sulla comprensione permette di superare gli ostacoli scolastici e di sviluppare autostima e consapevolezza dei propri punti di forza. Quando scuola, famiglia e professionisti collaborano, i DSA cessano di essere un impedimento e diventano una caratteristica individuale, una delle tante sfaccettature che rendono unica ogni persona.
Domande frequenti (FAQ)
Come si comporta un bambino con DSA?
Un bambino con DSA può apparire disattento, disorganizzato o lento nei compiti. Potrebbe evitare la lettura, mostrare frustrazione o ansia verso la scuola e avere una bassa autostima a causa delle difficoltà. È importante ricordare che questi comportamenti non derivano da pigrizia, ma sono la conseguenza diretta delle sue fatiche.
Chi fa la diagnosi di DSA?
La diagnosi di DSA viene rilasciata da un’équipe multidisciplinare composta da un neuropsichiatra infantile, uno psicologo e un logopedista. La valutazione può essere fatta presso il Servizio Sanitario Nazionale (ASL) o da specialisti privati accreditati dalle regioni.
I DSA possono scomparire con il tempo?
I DSA sono una caratteristica neurobiologica permanente, quindi non “scompaiono”. Tuttavia, con una diagnosi precoce, interventi riabilitativi mirati e l’uso di strategie e strumenti adeguati, una persona con DSA può imparare a gestire le proprie difficoltà e raggiungere ottimi risultati scolastici e professionali.
Fonte immagine: Foto di Valery: https://www.pexels.com/it-it/foto/laptop-internet-ragazzo-bambino-4103247/
Articolo aggiornato il: 13 Gennaio 2026