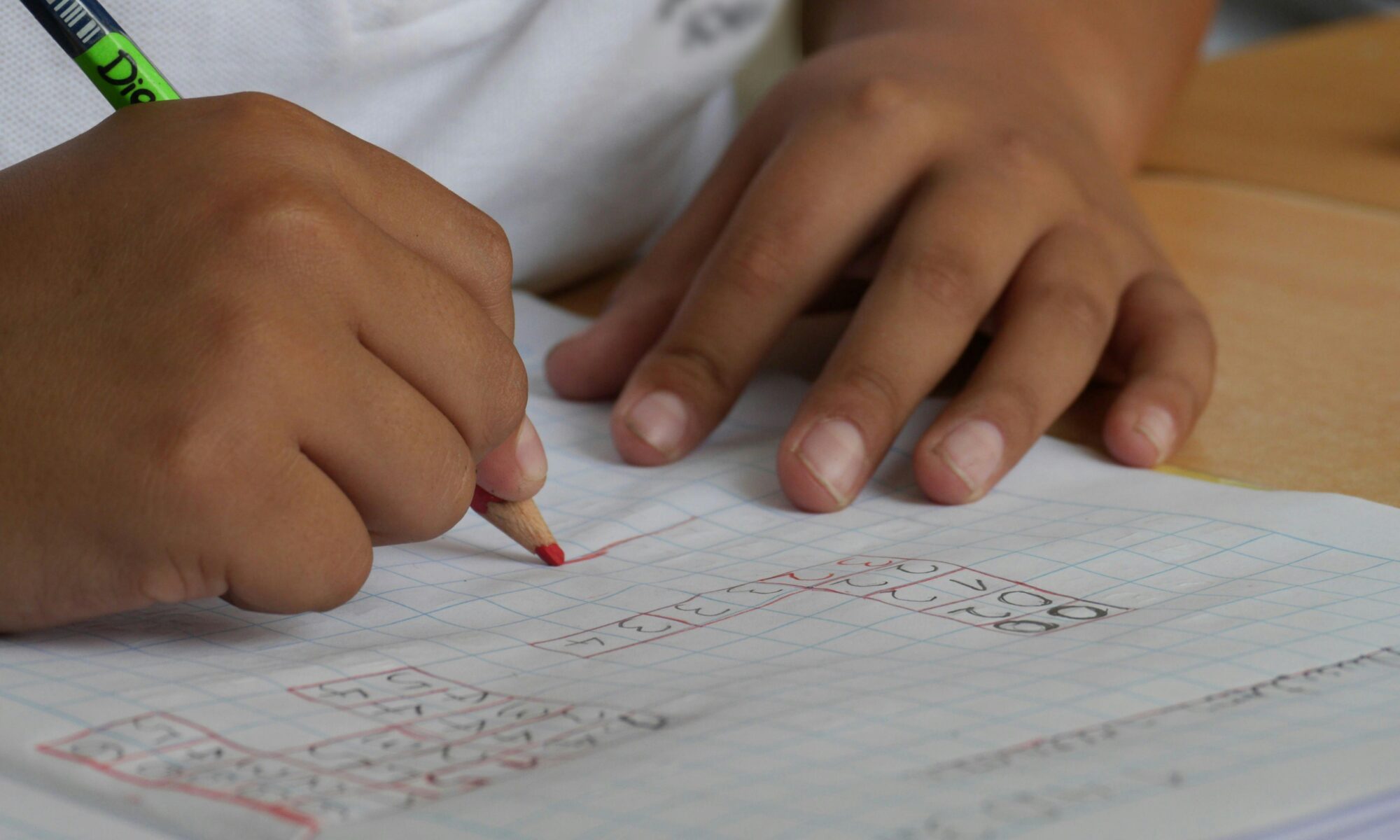I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) – che includono dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia – sono condizioni neurobiologiche che influenzano il modo in cui il cervello elabora alcune informazioni legate alla lettura, alla scrittura e al calcolo. È fondamentale comprendere che i DSA non sono legati all’intelligenza o alla motivazione di un ragazzo, ma a specifiche modalità di funzionamento cognitivo. Un ragazzo con DSA può essere brillante, creativo, capace di pensiero veloce e intuitivo, pur trovandosi in difficoltà in compiti che ad altri possono sembrare semplici e automatici.
Oltre agli aspetti scolastici, i DSA hanno un impatto significativo anche sulla sfera emotiva e psicologica. Molti ragazzi, infatti, non vivono solo la fatica di leggere o scrivere, ma anche il peso del confronto con compagni che sembrano “più veloci”, il timore di sbagliare davanti agli altri e la paura di non essere all’altezza delle aspettative di genitori e insegnanti. Per questo, affrontare i DSA significa anche parlare di autostima, ansia, frustrazione e di tutti quei vissuti emotivi che accompagnano la crescita di questi ragazzi.
Indice dei contenuti
- Come si sentono i ragazzi con dsa: la fatica invisibile
- L’influenza dell’autostima: gestire successi e insuccessi
- Dsa e ansia scolastica: un circolo vizioso da spezzare
- Strategie di supporto per genitori e insegnanti
- Come affrontare e prevenire le difficoltà emotive
- Oltre le difficoltà: talenti nascosti e opportunità
- Il ruolo degli specialisti e la legge 170/2010
- Domande frequenti (FAQ)
Come si sentono i ragazzi con DSA: la fatica invisibile
I ragazzi con DSA spesso sperimentano una sensazione di fatica costante. Attività quotidiane come leggere un testo o scrivere un tema possono richiedere un impegno molto superiore rispetto ai coetanei. Questa differenza, non sempre visibile dall’esterno, per il bambino o l’adolescente diventa un peso che si traduce in:
- stanchezza e affaticamento;
- frustrazione per gli sforzi che non sembrano portare ai risultati desiderati;
- perdita di fiducia nelle proprie capacità intellettive;
- rabbia, spesso in risposta a un senso di ingiustizia o inadeguatezza percepita.
Molti ragazzi riferiscono di sentirsi “più lenti” o “meno bravi” degli altri. Anche quando sanno che la difficoltà non dipende dalla loro volontà, il confronto con i compagni può diventare doloroso. Sviluppano l’idea che i propri sforzi non bastino mai, arrivando a interiorizzare un senso di inadeguatezza. Altri reagiscono con comportamenti di evitamento: si rifiutano di leggere ad alta voce o si distraggono. Questi atteggiamenti, spesso interpretati erroneamente come svogliatezza, sono in realtà strategie di protezione: meglio evitare una situazione difficile piuttosto che affrontare la paura del fallimento.
L’influenza dell’autostima: gestire successi e insuccessi
L’autostima svolge un ruolo primario nel percorso dei ragazzi con DSA. Ogni successo, anche piccolo, può rafforzare la fiducia in sé stessi, mentre ogni insuccesso rischia di alimentare la sensazione di “non essere capace”. Per questo, è fondamentale che i traguardi raggiunti vengano riconosciuti e valorizzati, non solo in termini di risultati, ma soprattutto di impegno e strategie messe in atto.
Quando un ragazzo con DSA percepisce che i suoi sforzi sono apprezzati, anche se non perfetti, sviluppa maggiore resilienza e motivazione. Un altro aspetto rilevante riguarda la comunicazione degli adulti. Frasi come “se ti impegnassi di più” minano profondamente l’autostima. È molto più efficace rinforzare i punti di forza e mostrare che l’errore non è un fallimento, ma un’opportunità di crescita.
DSA e ansia scolastica: un circolo vizioso da spezzare
L’ansia scolastica è una delle conseguenze più frequenti nei ragazzi con DSA. Sapere che leggere un brano ad alta voce o affrontare un’interrogazione comporterà difficoltà può generare anticipazioni negative, portando a un’elevata tensione emotiva. In alcuni casi, l’ansia può paralizzare le prestazioni, creando un circolo vizioso: più l’ansia aumenta, più la prestazione peggiora, alimentando ulteriormente il timore di sbagliare.
Questa ansia non riguarda solo le prove in classe, ma anche i compiti a casa. Alcuni ragazzi vivono ogni richiesta scolastica come una fonte di stress costante, con sintomi fisici (mal di pancia, mal di testa) e psicologici (paura di sbagliare, nervosismo, irritabilità). Con il tempo, il rischio è che l’ansia si trasformi in un evitamento generalizzato: rifiuto di andare a scuola, demotivazione e ritiro sociale. È importante che insegnanti e genitori sappiano riconoscere i segnali di ansia per intervenire tempestivamente.
Strategie di supporto per genitori e insegnanti
Sostenere l’autostima di un ragazzo con DSA richiede un’azione sinergica tra scuola e famiglia. L’obiettivo comune è rafforzare la fiducia in sé stessi e la resilienza.
| Approccio da evitare (luogo comune) | Approccio efficace da adottare |
|---|---|
| “Se solo si impegnasse di più, ci riuscirebbe”: questo presuppone che il problema sia la mancanza di volontà. | Riconoscere e lodare lo sforzo indipendentemente dal risultato. Frasi come “vedo quanto hai lavorato sodo” validano l’impegno e motivano. |
| “Gli strumenti compensativi sono un vantaggio”: vedere mappe o sintesi vocale come “scorciatoie” crea un senso di ingiustizia. | Presentare gli strumenti come occhiali per chi non vede bene: permettono di accedere alle informazioni alla pari degli altri. |
| Concentrarsi solo sulle materie scolastiche: definire il valore di un ragazzo unicamente in base ai voti alimenta la frustrazione. | Incoraggiare e valorizzare i talenti in altri campi (sport, arte, musica) dove può sperimentare successo e costruire un’identità positiva. |
| Evitare di parlare dei DSA: nascondere la diagnosi può far sentire il ragazzo “sbagliato” o solo, senza dargli modo di capire le sue difficoltà. | Parlare apertamente dei DSA come una caratteristica, non un difetto. Aiutarlo a comprendere come funziona la sua mente lo rende più consapevole. |
Come affrontare e prevenire le difficoltà emotive
Prevenire l’aggravarsi delle difficoltà emotive richiede un impegno sinergico. La prima strategia è creare un ambiente accogliente e comprensivo, sia a casa che a scuola. Gli strumenti compensativi (sintesi vocale, mappe concettuali) e le misure dispensative (tempi aggiuntivi, esonero dalla lettura ad alta voce) non sono “favoritismi”, ma strumenti essenziali che mettono tutti sullo stesso piano. Parallelamente, è fondamentale promuovere uno stile comunicativo che valorizzi i progressi e l’impegno, non solo i risultati.
Oltre le difficoltà: talenti nascosti e opportunità
È essenziale spostare il focus dalle sole difficoltà ai punti di forza che spesso caratterizzano questi ragazzi. Molti individui con DSA possiedono abilità notevoli:
- elevata creatività: una capacità di pensare fuori dagli schemi e trovare soluzioni innovative;
- pensiero visivo e spaziale: eccellono in compiti che richiedono la visualizzazione di concetti, come design o ingegneria;
- problem-solving alternativo: approcciano i problemi da angolazioni inusuali;
- intuitività e pensiero globale: tendono a cogliere il quadro generale piuttosto che i dettagli.
Coltivare passioni extrascolastiche, attività sportive o artistiche permette di sviluppare queste competenze, alimentando la fiducia in sé stessi e costruendo un’identità positiva.
Il ruolo degli specialisti e la legge 170/2010
Un percorso di supporto efficace inizia con una diagnosi precoce e accurata. Figure come il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il logopedista sono fondamentali per identificare il disturbo e suggerire le strategie più idonee. La Legge 170/2010 rappresenta un pilastro per i diritti degli studenti con DSA, garantendo il diritto a strumenti compensativi e misure dispensative. Come indicato nelle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, le scuole devono predisporre un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per promuovere un ambiente di apprendimento equo e supportivo.
Domande frequenti (FAQ)
Come si sente un ragazzo con DSA?
Un ragazzo con DSA spesso si sente frustrato, ansioso e affaticato. Può sviluppare una bassa autostima a causa del confronto con i coetanei e della sensazione che i suoi sforzi non siano mai sufficienti, portandolo a sentirsi “diverso” o “meno capace”.
Cosa non dire a un ragazzo con DSA?
È importante evitare frasi che colpevolizzano o minimizzano la sua fatica, come: “Sei pigro”, “Potresti fare di più se solo ti impegnassi” o “Non è così difficile, guarda i tuoi compagni”. Queste espressioni danneggiano l’autostima e aumentano la frustrazione.
Come aiutare un ragazzo con DSA ad avere più autostima?
Per aiutare un ragazzo con DSA, è fondamentale valorizzare l’impegno invece del solo risultato, incoraggiare le sue passioni e i talenti extrascolastici, utilizzare un linguaggio positivo e aiutarlo a comprendere che i DSA sono una sua caratteristica, non un limite alla sua intelligenza o al suo valore.
Fonte immagine: Pixabay: https://www.pexels.com/it-it/foto/ipad-d-argento-sulla-pagina-del-libro-bianco-289737/